
Aldo Rossi: la scenografia come condizione primigenia dell’architettura
 di Silvia Cattiodoro
di Silvia Cattiodoro
L’anno appena concluso ha portato con sé un importante anniversario: i 20 anni dalla scomparsa di uno pochi veri maestri italiani dell’architettura tra i protagonisti internazionali della seconda metà del Novecento, Aldo Rossi.
Nato nel 1931 a Milano matura fin da studente, una sensibilità del tutto personale per l’architettura, di natura metafisica derivatagli dallo studio di De Chirico oltre che della cultura e letteratura spagnola. Gli elementi apparentemente semplici della sua poetica avevano fatto dire che i suoi «disegni sembravano quelli dei muratori o capomastri di campagna che tiravano un sasso per indicare all’incirca dove si doveva aprire una finestra».
In realtà, fin dall’inizio le opere di Rossi si configurano come frammenti di un unico filo «in continua tensione verso un’impossibile totalità» (P. Fiorentini, Lo spazio della crisi, Sala Editori, 2001): la forma di collage con la quale egli riscrive a partire dagli anni ’60 l’architettura della città è chiara nelle sue opere più famose, dal Cimitero di Modena al Teatro Carlo Felice, il “teatro-piazza” per il caratteristico trattamento delle pareti interne come se fossero facciate urbane, nel tentativo di eliminare la storica frattura tra sala e palco generata dal boccascena.

 Se «la città è la scena fissa delle azioni dell’uomo» (A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, 1966), la scenografia per Rossi diventa utile soprattutto perché «conclusiva di un mondo costretto entro limiti reali» (A. Rossi, Autobiografia scientifica, The MIT Press, 1981): l’astrazione del volume conta a prescindere da tutto il resto, che sia la macchina per esperimenti architettonici in legno e lamiera chiamata Teatrino Scientifico, il Teatro del Mondo confuso con i palazzi nella bruma di Venezia o il Teatro Domestico montato sul vuoto dello scalone di Muzio nella Triennale dell’86, che si ripresenta nello stesso anno sotto forma di scenografia della pucciniana Madama Butterfly. Scrigno ligneo deputato all’attesa, alla speranza, al sacrificio e all’unione familiare che non si avvera, il grande oggetto si poneva drammaturgicamente al centro del palco come erede della tradizione costruttivista rivisitata nelle forme della tradizione giapponese nella quale si insinua il germe dell’Occidente: le due grandi colonne verdi che, invadendo il centro del piano terra, sostengono quelli superiori.
Se «la città è la scena fissa delle azioni dell’uomo» (A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, 1966), la scenografia per Rossi diventa utile soprattutto perché «conclusiva di un mondo costretto entro limiti reali» (A. Rossi, Autobiografia scientifica, The MIT Press, 1981): l’astrazione del volume conta a prescindere da tutto il resto, che sia la macchina per esperimenti architettonici in legno e lamiera chiamata Teatrino Scientifico, il Teatro del Mondo confuso con i palazzi nella bruma di Venezia o il Teatro Domestico montato sul vuoto dello scalone di Muzio nella Triennale dell’86, che si ripresenta nello stesso anno sotto forma di scenografia della pucciniana Madama Butterfly. Scrigno ligneo deputato all’attesa, alla speranza, al sacrificio e all’unione familiare che non si avvera, il grande oggetto si poneva drammaturgicamente al centro del palco come erede della tradizione costruttivista rivisitata nelle forme della tradizione giapponese nella quale si insinua il germe dell’Occidente: le due grandi colonne verdi che, invadendo il centro del piano terra, sostengono quelli superiori.
A fare da contrappunto a questo progetto, attinente alla sfera domestica più privata, la scena delle altre esperienze di lirica e balletto proviene dal felice incontro e dalla reciproca penetrazione di architettura reale e effimera, benché con modalità sempre diverse che generano riflessioni soprattutto sulla permanenza della forma.
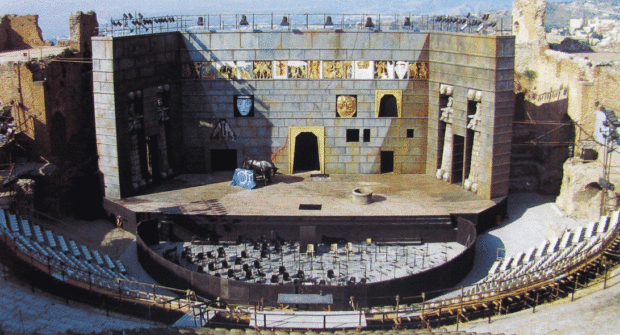
«Teatro o scenografia, scenografia o architettura quali altri mezzi per rappresentare sempre uguale la Storia?» si chiede Rossi nell’estate del ’92 davanti al teatro di Taormina che avrebbe ospitato la scenografia dell’Elektra di Strauss. Il muro del palazzo degli Atridi chiude il pittoresco squarcio sul golfo e abbraccia con due ali corte lo spettatore, riportando il teatro a luogo introverso e intimo. Il mito si insedia in un’architettura dall’aspetto di fortezza manicomio, risolta da un cortile e una facciata in lastre metalliche solcate da una inquietante crepa che trasuda sangue; e, tuttavia, non è indifferente al rapporto con il luogo, il teatro greco, né con le forme dell’architettura micenea in cui ombra e luce generano un contrasto parallelo a quello che agita il cuore della protagonista.

L’atemporalità delle forme stereometriche che fa del progetto scenografico, al pari di quello architettonico, la scrittura di un testo per frammenti è centrale nella riflessione che permea il balletto Raimonda di Glasunow commissionato dall’Opernhaus di Zurigo l’anno successivo. Al centro del palco, incorniciato da un doppio boccascena – l’uno stabile, connaturato alla struttura del teatro, l’altro effimero – campeggia un modello di città ideale. L’astrazione dei volumi e la riduzione materica e cromatica fanno del titanismo celebrativo tipico di certa architettura socialista orientale un misterioso giocattolo dall’ironia inquietante e mefitica, mitigato solo dall’arrivo del Saraceno che vela letteralmente con un drappo di seta la razionalità della costruzione e annebbia il cuore della protagonista. Il sogno dell’architettura sembra anche qui un incubo carcerario. Niente a che vedere con la rappresentazione dell’Oriente scanzonato dello Yatai di Pinocchio realizzato per il Japan Design Expo 1989 di Nagoya, tradizionale chiosco di cibo giapponese contaminato dalla cultura italiana, semovente così da poter sovrapporsi visivamente alle architetture della città che sta attraversando diventando una “permanenza temporanea”, un monumento effimero che lega luoghi a sapori perduti.

Anche nella Lucia di Lammermoor del 1986 il sentire metafisico si presenta nella cristallizzazione cimiteriale dell’ultimo atto, dove la tragedia si compie tra sepolcri marmorei dalle forme stereometriche: la rappresentazione della morte che attira e spaventa Rossi è sempre presente nel suo processo creativo. Ma vi è di più, e in questo l’opera messa in scena all’aperto va oltre la tradizionale percezione estetizzante dell’architettura rossiana. La scena nasce dalla sovrapposizione degli elementi temporanei con il reale skyline urbano percepito dietro la vera cortina di mattoni rossi della Rocca Brancaleone di Ravenna. Rossi opera da vero maestro del contemporaneo che sa che l’effimero è la condizione primigenia dell’architettura, in quanto gesto squisitamente umano, tentativo posto prima del definitivo; ed è altrettanto cosciente che la costruzione della città non può non passare dalla sovrapposizione evidente, benché armonizzata con sapienza, di epoche, stili, errori e trovate geniali, ma soprattutto di luoghi più o meno temporanei in cui l’uomo vive le sue vicende, perché la città è il teatro della vita degli uomini, luogo di cui stupirsi ogni giorno, così come ci si stupisce guardando uno spettacolo teatrale.
Il teatro è molto simile all’architettura perché riguarda una vicenda; il suo inizio, il suo svolgimento e la sua conclusione. Senza vicenda non vi è teatro e non vi è architettura. (Aldo Rossi)
 CENTRAL PALC Il tuo palco in Prima Fila
CENTRAL PALC Il tuo palco in Prima Fila



